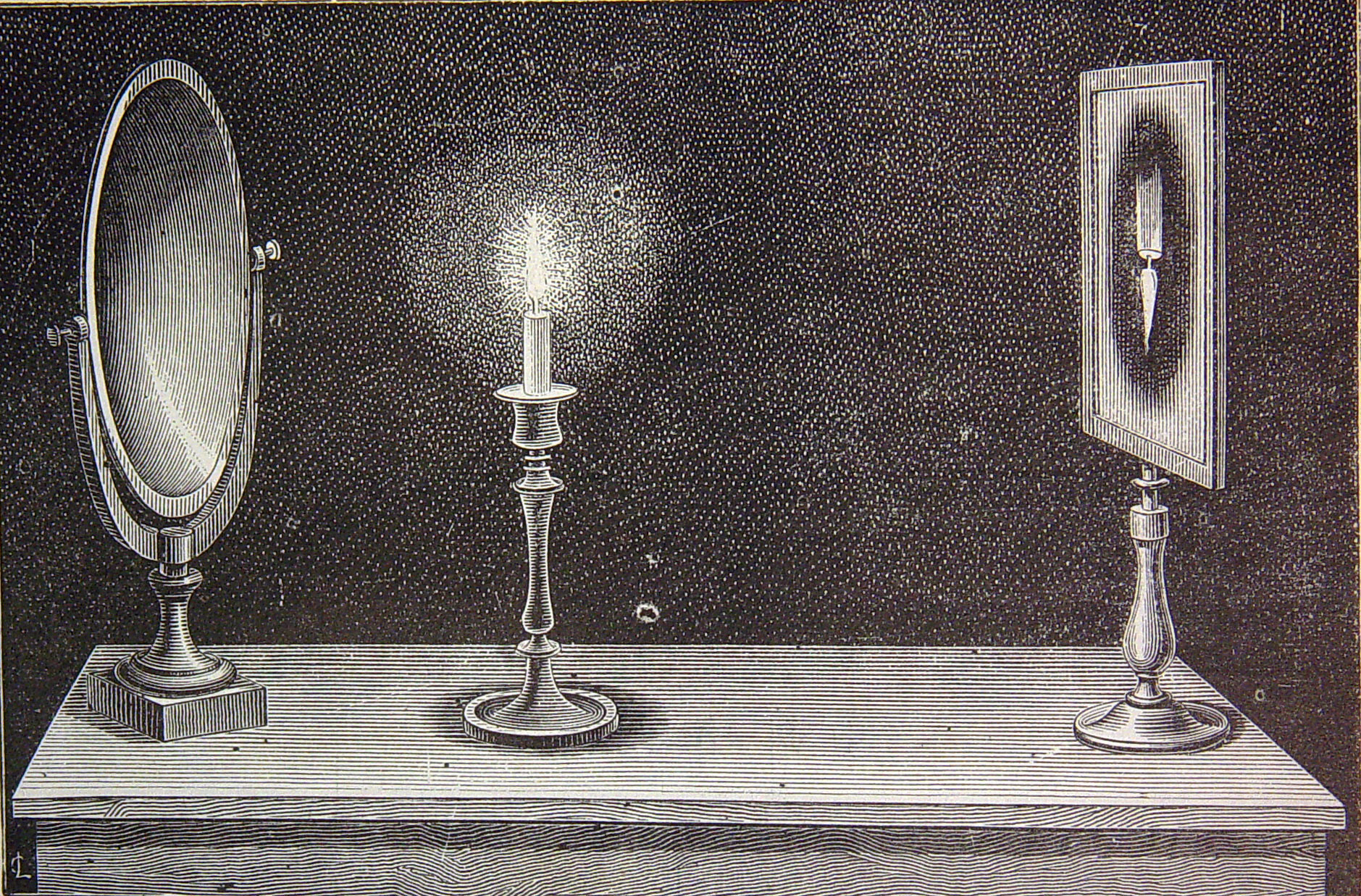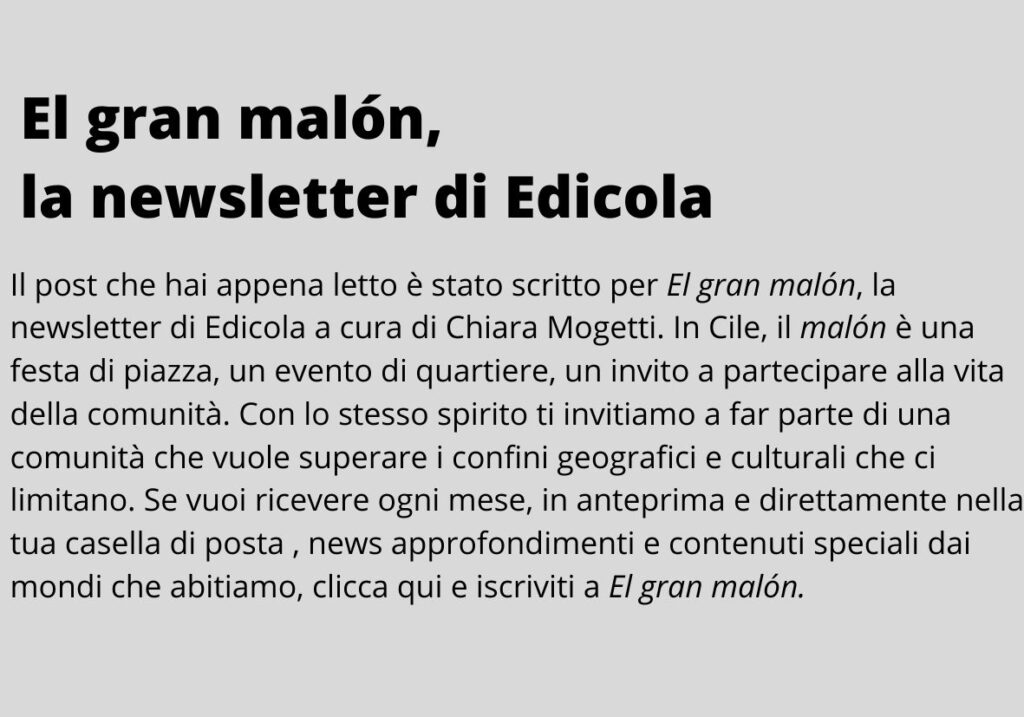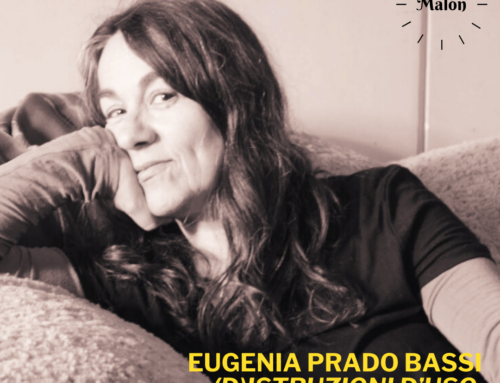Cos’è che del tema del doppio affascina – e inquieta – tanto secondo te? In letteratura questo topos è stato ampiamente esplorato, perché credi che abbia questo impatto nell’immaginario letterario?
NINA: Immagino che abbia a che fare, in primo luogo, con l’effetto prodotto dall’impossibilità. L’idea dell’impossibile. Oltre a questo, con ciò che l’impossibile significa per l’identità, questione tanto fondamentale nel nostro modo di vivere. Più o meno attaccati come siamo all’idea di identità, di personalità e alla loro stabilità. Quando queste idee si sgretolano, vanno in fumo o per un momento si pensano ridotte ai minimi termini, la possibilità del doppio diventa un fenomeno quasi giocoso. E ovviamente c’è anche la questione dell’unità dell’io che il doppio infrange. L’io si decentra, diventa altro. E l’altro sono io. È un’immagine molto potente perché radicalizza il gesto di vederci e scoprirci attraverso l’altro. L’altro in realtà è ciò che affascina, anche se ci rivolgiamo all’io per rappresentarcelo. Percepirci come un mistero rende la vita più interessante. Interrogarci ci spinge a mantenere l’attenzione. La natura è una grande maestra di questi temi, è piena di specchi.
MARTA: Quello del doppio è un tema che parla profondamente di noi in quanto esseri umani, credo. Non tanto della nostra dualità, quanto della nostra molteplicità. E di un aspetto che ossessiona Souza ancor più del suo doppio: la nostra unicità.
Semplificando, e cadendo in un pessimo gioco di parole, forse anche lo stesso tema del doppio ha due facce. L’arte in ogni sua forma altro non è che un racconto, e in quanto tale adotterà per forza uno sguardo parziale; il doppio è quindi un modo per allargare quello sguardo, per dotare il racconto di una prospettiva più ampia. D’altro lato, se penso alla molteplicità che ci appartiene, lo trovo quasi un rifugio, una semplificazione: il tentativo di trovare due volti (come facciamo da sempre: giorno e notte, buono e cattivo, maschile e femminile, reale e immaginario) che limitino le nostre sfaccettature, potenzialmente sconfinate, e ci aiutino così a definirle e a definirci.
Nina, qual è stato il processo di scrittura che ha portato alla nascita di questo libro? Come è nato? Da dove arriva?
NINA: È nato da questa immagine impossibile di un uomo, un operaio, che contempla il suo doppio, un altro da sé identico a sé stesso. Non è una scena molto originale, ma volevo scriverla. Volevo inoltre che quest’uomo fosse un lavoratore, qualcuno inserito in una routine, che posa un mattone sopra l’altro, come nella canzone di Chico Buarque, e che, tuttavia, può essere oggetto dell’insolito. Souza ad ogni modo è già un uomo insolito, che trovi sé stesso in un altro soggetto mi sembra venire dopo. Visto che avevo solo questa scena nella mia testa, ho pensato di scrivere un racconto, ma la presenza del protagonista era tanto forte, tanto nitida, con un corpo, l’intuizione di un volto, che ho provato a continuare il testo narrando i cambiamenti che, in qualche maniera, sentivo che stavano avvenendo nella mia città. Forse è strano, ma per me Souza esiste – oltre il testo, non incarnato in nessuno che io conosca. Lo sentivo coesistere con me mentre vivevo a Santiago. Quando me ne sono andata lui è rimasto e ho dovuto immaginare come continuasse a muoversi per la città.
Marta, esiste un modo per prepararsi o avvicinarsi alla traduzione di un libro? Se sì, qual è stato nel caso di Souza?
MARTA: Esistono senz’altro molti modi di esplorare un libro e i suoi dintorni. Utili per comprenderlo meglio, in primis, ma anche per fare un po’ più nostra la sua voce, o per trovare uno sguardo o un’atmosfera equivalente nella lingua di arrivo. La prima regola del buon traduttore sarebbe un’accurata esplorazione dell’opera dell’autrice, ma in questo senso la strada era breve e a fondo chiuso: Souza è il primo e unico romanzo di Nina Avellaneda. Non restava quindi che fare l’unica cosa possibile – e forse quella più sensata, sempre: lasciar parlare il libro. E calarsi nel suo immaginario. Nel caso di Souza, i sentieri percorribili erano diversi: quello letterario (Borges e Lispector, tra i primi), quello cinematografico (Bergman, per esempio. Mi tocca però fare ammenda: io questo l’ho scoperto solo più tardi, grazie a un sogno di Luiza, la protagonista, e una dritta di Nina), e quello a cui io sono fortuitamente approdata ancor prima di leggere il libro: la musica. Basta sfogliare Souza per rendersi conto di quanta musica ci sia nelle sue pagine; ma io non l’avevo ancora nemmeno sfogliato quando, cercando informazioni sul libro e sull’autrice, mi sono imbattuta in una playlist su Spotify creata da Nina Avellaneda e intitolata Souza. Così, ho deciso di rendere Souza la colonna sonora dei giorni precedenti alla lettura: ci ho trovato molti cantautori brasiliani che sarebbero poi risbucati tra i vinili di Luiza, ma anche Bob Marley, Los Jaivas e Beethoven. Solo in seguito ho scoperto che è stato anche il sottofondo sonoro di Nina durante la stesura del libro; e, per me, il modo più bello di entrarci.
Con Nina, poi, c’è stata una splendida intesa e collaborazione; se il confronto con l’autore è sempre arricchente, in questo caso è stato ancora più prezioso, perché anche lei (o forse un suo doppio?) è dentro il libro. Mi ha aiutata a sviscerare qualche dubbio linguistico e qualche citazione nascosta, sì; ma soprattutto a capire quale punto di vista adottare. Da lei ho voluto sapere dove fossero adesso Souza e Luiza, in un certo senso era importante. Che peso avessero il passato e il presente nella sua narrazione, stilisticamente eccentrica ed enigmatica. E poi, visto che questa è la prima traduzione in assoluto di una sua opera, l’ho avvisata che in traduzione spesso qualcosa si perde (e, nei casi più fortunati, qualcosa si guadagna) e ho cercato di capire che cosa Souza dovesse portare per forza con sé, in questo suo primo viaggio fuori dal Cile.