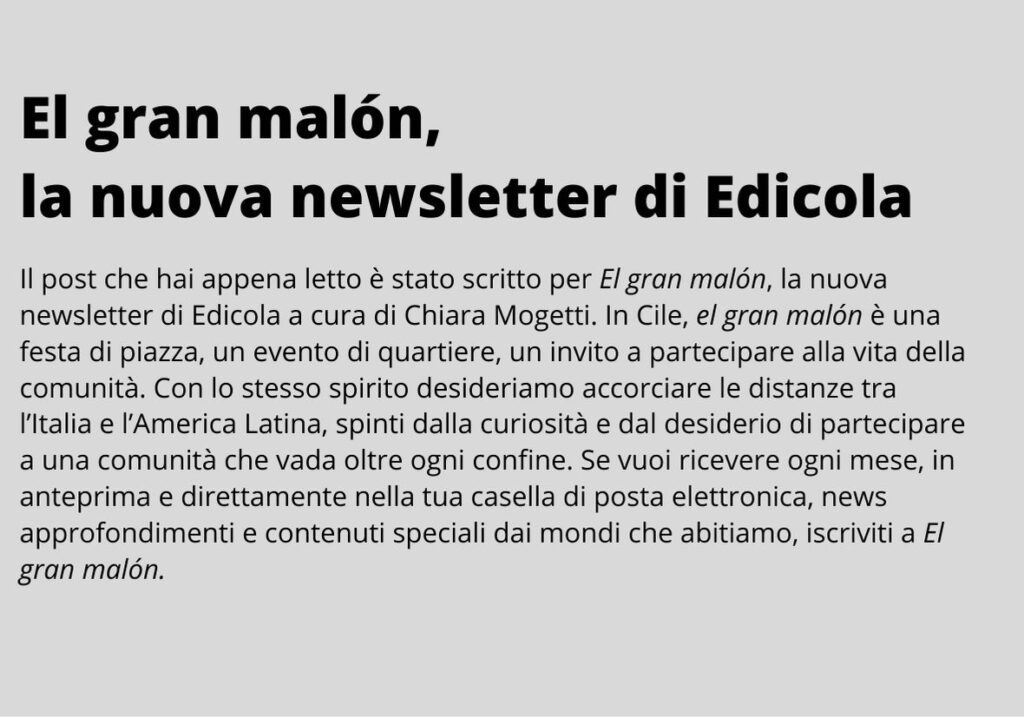Il Cile è sotto gli occhi di tutto il mondo mentre porta avanti la sua rivoluzione politica, sociale e culturale, culmine di un percorso cominciato due anni fa con l’esplosione delle proteste contro la crescente privatizzazione di servizi e risorse. L’inclinazione neoliberale che attirava sul paese le lodi dei governi del mondo si è dimostrata essere, invece, una china pericolosa verso la disuguaglianza, la povertà e la discriminazione. Con le elezioni che si sono tenute il 15 e il 16 maggio si è però sugellato un deciso cambio di rotta. Insieme ai 155 membri della Convenzione Costituente, i cui lavori porteranno a modificare la Costituzione di Pinochet, sono stati eletti governatori regionali, sindaci e consiglieri, in attesa delle elezioni parlamentari e presidenziali del prossimo 21 novembre.
Nonostante l’alta astensione dal voto e il proseguimento delle proteste, è riuscita a emergere dalle urne un’Assemblea Costituente senza precedenti, la prima al mondo composta in misura maggiore da donne – con un’inedita inversione del sistema delle quote di genere, che sono servite, in questo caso, a garantire la presenza maschile – e che assicura la rappresentanza dei popoli originari. Tra i volti di questo nuovo corso, per esempio, c’è quello di Francisca Linconao, autorità spirituale del popolo mapuche. Linconao è stata la prima donna mapuche a vincere in tribunale dopo essersi appellata alla Convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni (Nazioni Unite). Prima di essere assolta da tutte le accuse, è stata perseguitata, incarcerata e accusata di terrorismo dallo Stato cileno. Oggi fa parte dell’Assemblea che riscriverà la Costituzione.
Nel frattempo, le destre si sono viste aspramente sconfitte, con il prevalere degli indipendenti. Un risultato eclatante è stato l’elezione dell’economista comunista Irací Hassler a sindaca della capitale. La società civile sta finalmente entrando nelle istituzioni. Resta da capire se riuscirà davvero a cambiare le regole del gioco.
Abbiamo parlato dell’attuale situazione cilena con l’artista Francisca Yáñez. Nata a Santiago del Cile nel 1971, è cresciuta in esilio in differenti paesi, tra Argentina, Germania e Costa Rica. Il suo lavoro è fortemente influenzato da questa esperienza e dal conseguente incontro con culture differenti. Oggi vive e lavora a Santiago come illustratrice, disegnatrice grafica e artista visuale per case editrici e istituzioni legate alla cultura, all’infanzia e ai diritti umani. Con Edicola ha pubblicato il volume Alfabeto illustrato bilingue in italiano e spagnolo.
Nella tua vita, da quando avevi appena due anni, hai vissuto spostandoti in diversi paesi. Questa esperienza di esilio ha avuto un impatto sul tuo modo di intendere l’espressione artistica e la partecipazione politica?
Questa è la vita che mi è toccata e che mi ha plasmato, senza dubbio. Non so come sarei diventata se fossi cresciuta nel paese in cui sono nata. Come molti esiliati della mia generazione, c’è stato un momento in cui mi sono chiesta: cosa sarebbe successo se non ci fosse stato un colpo di stato? Ma è una domanda sterile, perché equivale a chiedersi cosa sarebbe successo se fossi nata in Danimarca o se mi fosse capitato di essere un pinguino. Da questo punto di vista, so soltanto di essere un prodotto della vita che mi è toccato vivere: mi hanno attraversato tutti gli esperimenti politici, non solo in Cile. Ho vissuto anche la Guerra Fredda nella Germania dell’Est e le agitazioni nell’America Centrale negli anni Ottanta. Tutti questi eventi, che per alcuni sono solo racconti dei libri di Storia, hanno un impatto sugli esseri umani. Nel mio caso è stato naturale che il mio modo di comprendere le cose avesse in sé una grande componente politica, perché tutto ciò che attraversava la vita della nostra famiglia alla fine aveva una risposta che trovava lì la sua origine. Dall’altro lato, l’arte era il mio porto sicuro, stabile. Dove potevo sempre rifugiarmi da tanta Storia. Solo con il tempo ho capito che l’arte è anche uno strumento di trasformazione e un gesto politico attivo, perché, semplicemente, non è possibile separarla dalla vita. Per questo, transito sempre tra due forme di partecipazione: attraverso l’arte e mettendo la mia opera al servizio di ricerche collettive da una parte e, dall’altra, con la partecipazione diretta, nel mio ruolo di cittadina, donna o vicina, associandomi alle istanze della mia comunità. Probabilmente la mia vita errante mi ha portato a porre l’attenzione o a essere più sensibile nei confronti di alcuni fenomeni come le migrazioni, il ruolo delle donne o i diritti dell’infanzia, e non perché abbia una particolare empatia, ma semplicemente perché so cosa significa non avere diritti. Se voglio fare un lavoro artistico mediamente onesto, inevitabilmente passo da questo, che è ciò che conosco. Sono cresciuta in una famiglia laica e con una cultura di sinistra e tutte le mie domande trovavano risposte possibili in territori molto concreti che derivavano dal politico e dal quotidiano. Qualunque comprensione e trasformazione necessariamente passava da lì. In fin dei conti tutti gli esseri umani e gli artisti fanno lo stesso: cercare risposte e tentare di comprendere il mondo.
Dopo la fine della dittatura, il Cile ha visto il ritorno di migliaia di esuli, che nel frattempo avevano attraversato il mondo. Questo sicuramente rende il paese demograficamente e culturalmente molto ricco e complesso. Credi che ciò abbia avuto un impatto sull’esito delle recenti elezioni?
In Cile è accaduto qualcosa di curioso quando è diventato possibile tornare, all’inizio della democrazia. In primo luogo ci hanno battezzato retornados, denominazione che immediatamente segna un limite e ti lascia fuori. È un paese in cui i limiti all’interno dei quali le persone si possono muovere socialmente sono molto marcati. Il problema di non aver elaborato le conseguenze della dittatura è che si fanno molte fantasie. Ancora a distanza di trent’anni persistono caricature e pregiudizi sull’esilio dei cileni semplicemente perché nessuno ne parla e nessuno si prende la pena di mettere in discussione la narrazione della dittatura per cui: “se la stanno passando alla grande in Europa”.
Ci è voluto tempo anche per riconoscere che le storie di esilio della prima generazione sono molto diverse da quelle dei figli che partirono molto piccoli o nacquero all’estero. In generale, non c’è stata un’accoglienza generosa di coloro che tornarono e ancora oggi mi tocca ascoltare supposizioni crudeli. Quando arrivai in Cile solo una persona (sconosciuta) mi disse “benvenuta”, nessuno mi chiese come stessi e ci misi molto tempo a stringere legami. Scoprii poi che questo non accadde solo a me, ma alla maggior parte delle persone della mia generazione. L’unico modo per integrarci era fingere che non fosse accaduto nulla, come se fossimo cresciuti lì, perché non era accettabile essere diversi. Tanti di coloro che tornarono erano intenzionati a contribuire alla democrazia con ciò che avevano appreso da questa esperienza (molti ebbero l’opportunità di formarsi) ma pochi trovarono un posto per sé. È dovuta crescere una generazione più spregiudicata per la quale non conta da dove vieni, ricettiva a ciò che accade al di là dei confini del paese, per cui penso che silenziosamente, durante questi decenni, forse alcuni di noi hanno effettivamente portato altre idee e visioni, nutrendosi nel frattempo di quelle locali.
Ancor di più nei risultati delle elezioni vedo un legame con la sensazione di non appartenenza. Forse è la prima volta che abbiamo qualcosa in comune. Tutte le mobilitazioni hanno condiviso il filo rosso dell’esclusione, del sentire che il paese non ti appartiene, e questo è stato un punto d’incontro importante per avviare il cambiamento. Mi sono sentita cilena per la Rivolta del 18 ottobre, ho sentito di appartenere e mi azzardo a dire che è accaduto lo stesso a molti che sono cresciuti fuori dal paese. Mi piace l’idea che abbiamo potuto apportare silenziosamente visioni diverse, semplicemente perché abbiamo interiorizzato l’idea per cui non c’è un solo modo di fare le cose e che si può uscire dai limiti imposti o auto-imposti.

Figura realizzata con fogli di carta raccolti nelle barricate di Santiago del Cile a ottobre 2019
Nel tuo lavoro si combinano la levità dell’infanzia e l’intensità oggettiva, materiale e drammatica della Storia. Puoi raccontarci della tua ricerca artistica?
Probabilmente nell’arte cerchiamo sempre risposte alle stesse domande. Lavorare con materiali e supporti diversi, tra la pittura e il disegno, la grafica e l’installazione, significa cercare modi con cui metterli in relazione tra loro. Per me è importante che l’arte sia un’esperienza incorporata alla vita quotidiana come un’ulteriore forma di conoscenza. Ho trovato nei libri e nel lavoro con bambini e bambine una forma democratica di farlo. Anche questa è una decisione politica, una specie di militanza, però perché non sia una mera riproduzione di idee è necessario che ci sia uno scambio di sensibilità. Il modo più onesto di farlo è offrire uno sguardo dalla mia storia per farla conversare con quelle degli altri. Lavoro con carte e documenti recuperati perché in essi trovo una dimensione poetica per raccontare storie e, quando li consegno ad altri perché costruiscano il proprio immaginario, questi incontrano i propri ricordi. Recuperare le carte per costruire una storia nuova è il mio modo di raccontare una memoria collettiva. È fragile, potrebbe essere rotta, ma si può sempre recuperare e, cosa più importante, si può generare un discorso nuovo che dialoghi con altri. Anche come società stiamo cercando di costruire prospettive di futuro ma non possiamo continuare se non guardiamo indietro e al tempo stesso lateralmente e oltre i nostri limiti. Lavorare con la migrazione mi costringe a uscire da me stessa e a conversare con l’altro senza pregiudizi.
Ho realizzato una delle mie ultime opere con pezzi di carta che ho raccolto durante le proteste dell’ottobre 2019. Vivendo nella zona delle manifestazioni, presi a scendere in strada ogni mattina, a raccogliere resti bruciati sulle barricate, e cominciai a costruire oggetti. Non potevo lasciare che finisse tutto in cenere. Di sera partecipavo come cittadina alle proteste di piazza, soprattutto per appoggiare i giovani, e la notte lavoravo tra gli elicotteri durante il coprifuoco. Avevo bisogno di trasformare la necessità collettiva di bruciare tutto in qualcosa di permanente, che conservasse le tracce della Storia. È un gesto che viene molto naturale con i bambini. Sono capaci di costruire un’intera città con un nulla e di darle un senso nuovo.
L’orientamento universalista delle sinistre entra spesso in conflitto con la molteplicità di identità, appartenenze, punti di vista ed esperienze che vi cercano una casa. L’esperienza costituente in corso in Cile sembra invece partire proprio dal riconoscimento di questa pluralità. Credi sia davvero possibile una politica capace di affrontare le intersezioni tra differenze e diseguaglianze?
Sussiste una contraddizione permanente tra il carattere segregato della società cilena e la diversità che vi è sempre stata ma che si fingeva non esistesse. Alcuni si spaventano per questa irruzione della differenza: i detentori del potere hanno reagito marcando i limiti, anche provocando e disprezzando un fenomeno che consiste sostanzialmente nel popolo che pensa a sé stesso. Appaiono ora evidenti le fratture che dividono il paese. Convivere con la diversità non è mai stato facile: significa affrontare i nostri conflitti senza gettare tutto all’aria.
L’intenzione di convivenza può farci crescere e richiede molta generosità. Noi adulti dobbiamo metterci a disposizione dei giovani perché riescano in questi cambiamenti e loro dovranno essere ricettivi al nostro contributo, ognuno dal suo punto di vista. E i protagonisti degli ultimi decenni devono capire che si può accettare di essere attori secondari perché la voce di altri possa essere ascoltata.
Le strutture più rigide sono più difficili da adattare e quando si trattiene la forza da un solo lato è più facile che si rompano. Questo riguarda anche la sinistra: a me non interessano le rivoluzioni che si guardano l’ombelico, di solito finiscono molto male. Solo capendo che questa molteplicità è composta da particolarità possiamo costruire un insieme. Come i frammenti che raccolgo, ciascuno mantiene la sua storia e dialoga con gli altri senza annullarsi.

Errant”, settembre 2019, Draw International, Caylus, Francia
Come hai vissuto, insieme alla tua famiglia, ai tuoi amici e alla tua comunità, questa svolta? Cosa credi che sia ancora necessario fare e cosa speri per il futuro?
Da un punto di vista più legato alla mia quotidianità, si è trattato solo di un’estensione di qualcosa che già conosco. Ho sempre cercato spazi per contribuire come posso ai bisogni collettivi e per fortuna ho l’arte, perché sarei una pessima attivista. A un livello più personale, mi sono sempre circondata di persone diverse che si sono impegnate in questo lungo processo, che non si è generato da un giorno all’altro, ma si svolge da decenni in spazi diversi. La differenza è che questa volta è stato più intenso e rapido, nonostante la pandemia. Prima di questa, la mia cerchia ristretta era diventata il luogo in cui elaborare ciò che stava accadendo. In maniera del tutto spontanea, abbiamo trasformato le nostre case in luoghi di discussione, ci siamo informati, abbiamo realizzato cicli di film e documentari. Anche partendo da esperienze molto diverse abbiamo iniziato a trovare punti di unione e posso dire che ho imparato molto dai loro punti di vista, e penso che loro abbiano imparato da me. Molte idee che davo per scontate sono cambiate radicalmente e il mio pensiero ricorrente era: taci, osserva e impara. Nella mia cerchia familiare la situazione era simile, in qualche modo sentivo che avevamo passato una vita a prepararci a questo momento. Abbiamo già vissuto una rottura drammatica nella storia, che però non ci ha disarmati: è stato un vantaggio incontrarsi tra generazioni diverse con l’intenzione di sostenere questo processo. Sono cresciuta in una famiglia dove si respirava la discussione politica, con lunghe conversazioni a tavola in cui mi si chiedeva quale fosse la mia opinione; ora si tratta della stessa tavola ma con idee in continua evoluzione, una tavola dove la disposizione cambia a seconda di ciò che passa fuori dalla finestra, senza però dimenticare da dove veniamo e rispettando profondamente la voce dell’altro. Non ho risposte riguardo a cosa bisogna fare, perché probabilmente dobbiamo continuare a inventare nuove formule e mettere in discussione ciò che davamo per scontato. Non possiamo guardare le cose con la stessa logica di due anni fa, non può esserci intelligenza senza incorporare la sensibilità che è stata tanto vituperata dall’establishment dominante. “Più passione e più amore”, disse una volta Salvador Allende; sento che è tempo di non dimenticarlo e non c’è niente che dia più prospettiva del desiderio di una vita più gentile. Credo sia fondamentale mettersi in gioco da un qualsiasi spazio che vada oltre le proprie mura, per prendere posizione. La mia aspirazione è che si possa costruire una base di accordo in cui il rispetto dei diritti umani sia il punto di partenza di ogni discussione, con una sanzione etica per chi si ostina a minimizzarlo. Riguardo al resto, credo si procederà per prove ed errori, ma sempre partecipando in maniera attiva al processo che ci ha permesso di eleggere democraticamente chi ci rappresenterà in questo difficile percorso.