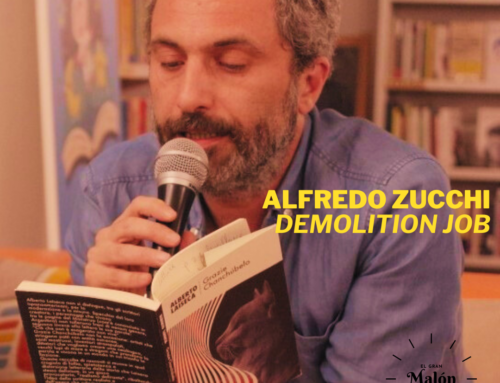Desiderio e presenza, documento e finzione, memoria e invenzione, pazienza e frenesia: la scrittrice cilena Alejandra Costamagna, di cui Edicola ha pubblicato la raccolta di racconti C’era una volta un passero e il romanzo Il sistema del tatto, torna, in questo nuovo appuntamento del Malón, a raccontarsi ai suoi lettori in Italia, portando tutta la complessità di un’esperienza e di una visione del mondo che non si lasciano mai ridurre a significati assoluti.
Vuoi raccontarci a cosa ti sei dedicata in questi ultimi anni, così intensi per il Cile e non solo?
Per quanto riguarda il Cile, credo che siamo ancora scossi dalle rivolte del 2019 [NdR: le accese proteste che hanno rimesso in discussione il modello neoliberista ereditato dalla dittatura], dalla pandemia e dal fallimento dei tentativi di rinnovamento della nostra Costituzione, ferma ancora all’epoca della dittatura. È stato un periodo di apprendimento e disapprendimento, mentre ci sforzavamo di aprire i nostri occhi su nuovi scenari, cercando di capire un mondo sottosopra. Ed è stato anche un periodo per riflettere sull’assurda frenesia che ci affligge, sulle pretese di un modello di iperproduttività che ci richiede di essere presenti in ogni cosa, di produrre, produrre e produrre, di avere risposte che a volte riusciamo a malapena a balbettare. Penso che questa velocità, questa urgenza neoliberista che lavora sull’obsolescenza quasi immediata, questo “fare” costante e soverchiante, sia una malattia del sistema a cui dobbiamo fare attenzione. Nella mia pratica letteraria degli ultimi anni, per questo, ho cercato di frenare e di assecondare la lentezza che un testo richiede, di fermare la macchina tutte le volte che è necessario per elaborare, dare un senso, mettere in discussione, riassemblare, immaginare, rinunciare, scompigliare e tornare a passare per il cuore.
Dal tuo lavoro, in particolare da Il sistema del tatto, emerge uno stretto rapporto con l’Italia: vuoi parlarcene?
Questa stretta relazione è un’eredità genealogica. Posso illustrare questo rapporto con una scena che ha rappresentato la prima scintilla del romanzo Il sistema del tatto. Mio padre, argentino, mi parlava di suo nonno piemontese, emigrato nel 1910 e mai tornato. E mi raccontava che il vecchio gli parlava della sua terra, della casa sulla collina, della stalla, di un certo cavallo, dell’aria della campagna, delle strade acciottolate. Quando il nonno morì, si perse ogni contatto. Molti anni dopo, mio padre si recò in quel paesino piemontese, entrò in uno dei pochi ristoranti presenti e venne fuori che il proprietario era suo nipote. Arrivò quindi tutta la famiglia, con le fotografie inviate dall’Argentina a metà del Novecento dai nonni di mio padre, intatte. Foto sopravvissute agli spostamenti da un continente all’altro, ai rigori di due guerre mondiali, agli incendi, ai nascondigli e alla polvere di un intero secolo. Quello in cui hanno visitato la casa sulla collina è stato il momento chiave: era esattamente lo stesso paesaggio del racconto orale del vecchio. Al ritorno dal suo viaggio, mio padre mi ha raccontato tutto e, in quel momento, mi è sembrato di essere lui, mentre ascoltava il racconto di suo nonno. L’immagine di un’immagine.
Nel 2011 ho seguito lo stesso percorso, ho incontrato i parenti e ho chiesto loro di portarmi alla casa. Quando ho visto la stalla, la collina e la casa intatte, mi è sembrato che il cavallo fosse lì da sempre, a mangiare la stessa erba di secolo in secolo, con gli occhi fissi su un paesaggio senza tempo. L’idea di un passato che getta scintille nel presente è stata come una folgorazione. Ho anche pensato, però, che non ero lì per ricostruire la storia, ma per soffermarmi nei vuoti della memoria e osservarne, con attenzione chirurgica, gli strappi e le pieghe. Anche se quel momento in particolare è rimasto fuori dal romanzo, ne è alla base. E ha innescato la stesura di una storia che ruminavo da anni, anche se poi, naturalmente, questa ha deviato e si è ramificata in altre direzioni.
Il sistema del tatto, quindi, è nato dal desiderio di scrivere una storia non finzionale. Volevo indagare sui migranti che tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo dal Piemonte italiano erano arrivati nella provincia argentina. L’esperienza dei miei bisnonni ne faceva parte. Ma lungo il percorso mi sono imbattuta in altre ondate migratorie e in altre esperienze di sradicamento che andavano oltre la migrazione propriamente detta. E questo tema ha cominciato a imporsi: il presente ha cominciato a pretendere di partecipare e con il presente sono arrivate le domande, le mezze verità, le speculazioni e il via vai tra documento e immaginazione. E il montaggio, l’assemblaggio di pezzi, frammenti, scene, il lavoro con i residui e i sedimenti di cui è costituita la memoria, ha assunto grande importanza. Il risultato è una sorta di album di famiglia entrato nella finzione.
E per quanto riguarda invece C’era una volta un passero?
C’era una volta un passero è nato dalla proposta di ripubblicare il mio primo romanzo, En voz baja. Quando lo scrissi, negli anni Novanta, volevo capire come una frattura sociale che aveva fatto crollare un intero Paese si riflettesse nei piccoli nuclei e nella vita quotidiana. Ma non mi interessava rappresentare in modo esplicito o documentale i fatti, bensì addentrarmi dietro le porte chiuse, nelle crepe all’interno delle famiglie, in ciò che rimaneva fuori fuoco, nei dettagli e nelle sfumature della crisi, negli incubi e nelle fantasie che si risvegliavano in quanti erano privi degli strumenti per interpretare il cambiamento. E soprattutto nei silenzi, è lì che mi interessava inoltrarmi. Nel 2013, quando mi è stato proposto di tornare a pubblicare il romanzo dopo quasi vent’anni, ho chiesto del tempo per correggere qualche dettaglio. Ma è successa una cosa: il respiro del libro originale mi era estraneo, sentivo che mancava di concentrazione espressiva, che c’era più rumore del necessario. E così è venuta fuori una scrittura laterale, con un altro registro per la stessa storia, concentrata in 30 pagine invece di 170. A questo materiale si sono aggiunti gli altri due racconti del libro attuale.
In entrambi i casi il punto di vista infantile è determinante nella costruzione narrativa, tra l’altro collocando il lettore in una dimensione familiare e privata, personale. Nel frattempo, le vicende della storia si muovono sullo sfondo, cambiando le vite di bambini che, però, non le comprendono fino in fondo, pur subendone gli effetti. Vorresti parlarci di questa scelta?
C’è una frase di Gabriela Mistral che mi piace e che mi pare molto in sintonia con la domanda: “Posso correggere nel mio pensiero e nella mia lingua ciò che ho imparato nelle età brutte – adolescenza, giovinezza, maturità – ma non posso cambiare le radici delle espressioni ricevute nell’infanzia”. Vista dall’età adulta, l’infanzia è una straordinaria miniera per riflettere sul linguaggio, per metterlo in discussione, per rimescolarlo, per fargli dire ciò che non dice. Nell’infanzia, inoltre, c’è qualcosa di estraneo alla razionalità degli adulti, di molto meno definito, a fior di pelle, che è molto accattivante per me. La casa immaginaria dell’infanzia è un luogo ricchissimo: è lì che tutto ha inizio. Fantasia e crudeltà, entusiasmo e orgoglio. Mi piace pensare al possibile bagliore del selvaggio che vi abita. Cercare di cogliere anche solo una scintilla di quello spirito sulla pagina.
Il rapporto con la memoria da una parte e i rapporti familiari dall’altra: diresti che questi due temi sono un filo conduttore della tua opera? Entra forse in gioco la nostalgia come bussola della tua immaginazione?
La memoria e le relazioni familiari sono come un fiume molto generoso nel suo fluire, che adotta forme diverse a seconda di ciò che l’immaginazione va modellando per conto proprio. La memoria, l’immaginazione e la storia non smettono mai di inseguirsi a vicenda. Per quanto riguarda la parola nostalgia, invece, vorrei fare un discorso a parte. Etimologicamente la parola è composta da nostos (ritorno a casa, alla patria, all’origine) e algia (anelito). E credo che nei miei testi l’algia abbia più peso del nostos. In altre parole, è l’anelito ad avere la precedenza, il desiderio mobilitato nel presente. Penso a quanto dice Svetlana Boym, che distingue tra nostalgia “riparativa” e “riflessiva”. E a proposito di quest’ultima, che sento più vicina, dice che “non percorre un’unica traccia, ma esplora modi di abitare più luoghi contemporaneamente e di immaginare spazi temporali diversi. Ama i dettagli più dei simboli”. I dettagli, le contraddizioni, i “ma” dei personaggi, le loro inaspettate zone grigie, mi interessano molto più dei simboli.
Mi sento vicina alla mia generazione, con cui condivido un’esperienza collettiva che abbiamo trasformato in letteratura attraverso strategie e registri diversi. Ma ci sono giorni in cui l’affinità diventa molto specifica e trascende le cordigliere: allora mi sento molto vicina ad autrici come l’uruguaiana Inés Bortagaray o l’argentina Paloma Vidal, ai loro sguardi singolari, al loro modo di rapportarsi all’infanzia, al loro modo febbrile di portare in scena le parole come se fossero colpi, o schegge. Per quanto riguarda il Cile letterario attuale, direi che esiste una comunità opportunamente eterogenea e che parte di questa diversità è sostenuta dal duro lavoro delle case editrici indipendenti.
A cosa ti piacerebbe dedicarti nel prossimo futuro?
Finire un romanzo a cui sto lavorando e non avere fretta nel farlo, coniugare urgenza e pazienza.