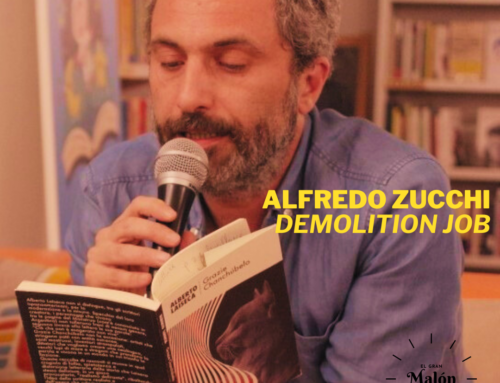Personaggi in fuga e germinazioni impreviste, prodigi organici e sgomento cosmogonico, bestie, palazzi e giardini, l’origine del mondo e la sua fine: Le favole nuove di Livio Santoro coglie in ventotto racconti un immaginario dal respiro amplissimo, che tiene insieme l’orizzonte di senso del mito e le prospettive plurali e orizzontali del pensiero postumano. Ventotto brevi storie visionarie che dilatano le parole, le immagini e i pensieri.
Dopo Piccole apocalissi e Commedie del vespero e della notte, Santoro popola il suo ecosistema letterario di un nuovo esemplare: Le favole nuove è il complemento di un’opera narrativa che trova la propria originalità non solo in un uso del linguaggio denso e generativo, ma anche in una vasta e brulicante rete di relazioni e risonanze con altri immaginari e strumenti espressivi, dalla filosofia, alla musica, alle arti figurative. In questa intervista l’autore ce ne offre un assaggio.
In che relazione si pone Le favole nuove con le tue raccolte precedenti, Piccole apocalissi e Commedie del vespero e della notte? Possiamo considerarla una trilogia? Cosa unisce e cosa distingue le tre opere?
Se vogliamo possiamo considerarla una trilogia – anche se tra le Commedie e le Favole il legame è molto più forte. Nei tre libri ci sono vari motivi, temi e personaggi ricorrenti. Cambiano però il modo e il posizionamento morale con cui sono trattati, radicalmente. Faccio un esempio: nelle Commedie un personaggio mendico viene marginalizzato e offeso finché accumula talmente tanta rabbia ribollente da fagocitare la città in cui vive, sotto forma di una cupola di carne che pulsa. Nelle Favole c’è un personaggio del tutto simile, solo che lì le persone si spendono per dargli da mangiare tutto quel che possono, con una sorta di ingenuità solidaristica utile più a loro che al protagonista del racconto, il quale a furia di mangiare diventa, anche qui, una montagna di carne che sovrasta tutto.
Poi, se nelle Apocalissi c’è uno sguardo più quotidiano e umano, così come le ambientazioni sono spesso riconoscibili, attuali e domestiche, nelle Commedie tale dimensione si dissolve, per fare i conti con un’aria cupa e catastrofica di perdita, in un mondo straniato e post-apocalittico; nelle Favole c’è invece l’accettazione di questa perdita e della prospettiva della fine, grazie alla quale emergono tentativi di generare nuove cose. Tutte le Favole sono racconti di genesi, nascite, cosmogonie, mutamenti. Anche la morte, quando c’è, è generativa. Come ha detto Alice Rifelli, Le favole nuove è senza dubbio il libro più “luminoso” dei tre e l’allontanamento dall’atmosfera asfittica che caratterizzava in crescendo i due titoli precedenti dovrebbe emergere anche dall’ampiezza dei racconti, in media più lunghi.
Attraversa i racconti una sorta di regressione dell’elemento umano e il cambiamento del suo rapporto con l’ambiente, che si fa più morbido, provvisorio. Un nuovo stato di necessità che si afferma? O il ritorno di uno antico, “primitivo” o “primigenio”?
Non mi sento un sostenitore del primitivismo o di posizioni à la Thoreau, anche se di certo ne subisco il fascino. Se nel libro un cenno al primitivismo o all’Arcadia c’è, e in effetti un po’ c’è, l’argomento viene trattato in termini caricaturali. Penso per esempio a “Il melo”, i cui protagonisti vivono con tanta idilliaca leggerezza da sembrare quasi dei fessi.
In “Memoria del prima”, invece, i protagonisti fuggono, non si sa da cosa o da chi. Forse sanno dove vogliono andare o forse no. Non è importante per noi saperlo. È importante però sapere che alla fine, quando decidono di fermarsi, non lo fanno per ricostruire o ricominciare, ma per godersi quel che resta nel tempo che rimane, facendo affidamento solo sul poco che hanno. Magari generano un’eredità sotto forma di storie e racconti, ma molto probabilmente nessuno la raccoglierà. Se vogliamo tirare fuori una morale, può riguardare l’affrancamento dalla posterità, ma non nei termini negativi della sottrazione di qualcosa a chi verrà. Perché probabilmente, alla fine di tutto, non ci sarà nessuno a leggere, a guardare, ad ascoltare.
Non mancano i riferimenti a diversi sistemi di conoscenze e immaginari, dall’antropologia al pensiero ecologico e postumano, che vede in Donna Haraway l’esempio più noto. Per esempio, nel racconto di apertura “Memorie del prima” scrivi di disegni rupestri che parlano di “parentele”, un termine carico da diversi punti di vista. Vorresti parlarci della rete di riferimenti a campi del sapere e discorsi diversi che hai intessuto e al valore che assume nella tua scrittura?
“Parentele” è un termine programmatico che trova una traduzione narrativa specifica in molti dei racconti successivi (e nella fantastica copertina di Tite Calvo). In questo senso “Memorie del prima” fa da vera e propria introduzione al libro. Quando scrivo “parentele” dichiaro esplicitamente il modello che ben identifichi. Nelle Favole, come nelle Commedie, mi piace pensare che oltre a un po’ di Haraway ci sia anche un po’ di OOO (Ontologia Orientata agli Oggetti) e di Reza Negarestani, per non fare una lista troppo lunga: perché mi piace scrivere storie che non hanno solo l’individuo umano al centro, storie spesso plurali, in cui le relazioni si intessono su vari piani biologici e geologici, senza trascurare (qui esagero) il piano cosmologico e astrale.
E questo sia per faccende di ordine politico che riguardano il mio posizionamento interno alla letteratura, dato che trovo spesso deludenti e ridondanti le storie che raccontano delle persone e soltanto delle persone; sia per questioni squisitamente narrative o procedurali, nella pratica della scrittura, dato che le possibilità d’intreccio diventano assai maggiori se non ci si limita al protagonismo assoluto degli esseri umani o, meglio, di un singolo essere umano che conduce la sua vita in una casa più o meno come la mia, con un lavoro più o meno come il mio e preoccupazioni più o meno come le mie.
Devo comunque dire che molti degli ambienti da cui traggo riflessioni sono musicali più che filosofici o letterari: oltre a essere un metallaro inveterato – amante di un genere che in alcune sue varianti più estreme ha il non-umano come elemento caratterizzante e che pesca nelle grandi narrazioni della mitologia – negli ultimi tempi sono piuttosto preso da un certo tipo di elettronica, come quella di Caterina Barbieri, e dalla drone-music. Cioè da ascolti che costringono a dilatare il pensiero e lo sguardo in maniera smisurata, imponendo ragionamenti che per me hanno avuto un forte impatto sul modo di esperire il tempo. E cito anche un pittore contemporaneo che mi fa sognare, Agostino Arrivabene: qualcosa che vive nelle Favole è sicuramente uscito fuori dopo aver visto le sue opere.
Emerge una significativa dimensione mitica nelle tue narrazioni. Trovi che abbiamo bisogno di un nuovo immaginario mitico?
Solo ieri forse avrei detto che ce n’è assoluto bisogno. Oggi, direi piuttosto che da un nuovo immaginario mitico si potrebbero trarre tante cose buone, in particolare nella sua traduzione e nel suo adeguamento alle nostre strategie di convivenza. Soprattutto nella misura in cui può aiutarci a superare la tirannia del qui e ora con cui siamo abituati a ragionare, cosa che in un certo senso avviene anche con il pensiero geologico.
Parlando invece di favole, tendiamo ad associare questa forma letteraria a un linguaggio semplice e diretto, denotativo. Nei tuoi racconti vai in una direzione diversa, con scelte lessicali desuete e stranianti. Vorresti parlare del tuo lavoro con il linguaggio?
Mi è sempre piaciuto scrivere in una lingua inattuale, sia utilizzando termini desueti e arcaismi, sia realizzando costruzioni sintattiche elaborate e talvolta perfino contorte o ampollose. Lo faccio per vari motivi, cause e scopi. Primo, perché vorrei chiarire da subito che nei miei racconti ci troviamo in un altro tempo e in un altro luogo rispetto al qui e ora che noi tutti viviamo. Poi, perché credo che in alcuni casi una lingua faticosa sia utile per descrivere una situazione faticosa (come succede nelle Favole con il racconto “Tristo il rivo di Calonia Vanià”, dove ho volontariamente spinto molto in tal senso). E, ancora, perché quelli che considero i miei riferimenti letterari italiani, o quantomeno le letture che più mi hanno coinvolto e mi coinvolgono, come Tommaso Landolfi e Michele Mari, non si risparmiano di certo sulla questione della lingua. Infine, c’è da dire che mi diverto proprio tanto a scrivere così, e quando scrivo mi voglio divertire. Per me scrivere è una festa.